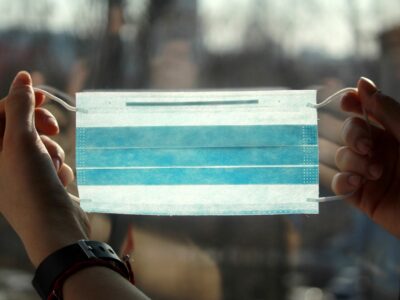Franca Maino: «Assistenza agli anziani, la sfida ora è una riforma»
Nei giorni scorsi l'Unione europea ha approvato il Pnrr italiano, che ha accolto alcune delle proposte avanzate nei mesi scorsi dal Network Non Autosufficienza. Per la sociologa Franca Maino è ora il momento di pensare a una riforma organica dei modelli di assistenza agli anziani. «Domiciliarità e istituzionalizzazione non sono modelli alternativi: devono coesistere ed essere entrambi oggetto di investimenti e innovazione, e anzi oggi il nostro Paese è carente proprio sul fronte della residenzialità».